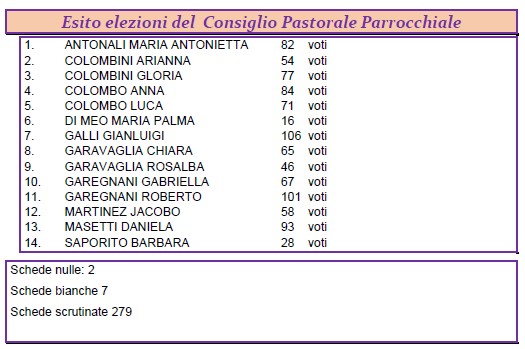Essere cattolici significa essere aperti e capaci di dialogare anche con chi non si riconosce nella nostra fede
di Luca Bressan – vicario episcopale per la cultura, la missione e l’azione sociale della diocesi di Milano
Il clamore e le numerose polemiche suscitate dalla decisione dell’Istituto comprensivo “Iqbal Masih” di Pioltello (Mi-lano) di sospendere le lezioni lo scorso 10 aprile, in occasione della festa per la chiusura del Ramadan (per non obbligare molti alunni — che per oltre il 40% sono di religione islamica — a scegliere tra la partecipazione ai riti religiosi e la presenza alle lezioni) non soltanto si sono placati ma anche dimenticati. Sommersi — com’è ormai abitudine — dal flusso ininterrotto della comunicazione mediatica che copre con la novità delle ultime notizie le precedenti. Dimenticare in questo caso è però un’operazione rischiosa, che ci fa disperdere quanto abbiamo imparato da tutta la vicenda. Soprattutto, dimenticare signifca coprire la sfida culturale che abbiamo davanti agli oc-chi, come cittadini e come credenti. La Chiesa ambrosiana ha scelto di schierarsi, appoggiando la decisione presa dalla scuola, perché il dibattito da subito ha spostato la questione sul terreno dell’identità cristiana o cattolica del nostro Paese, e del rapporto tra le religioni. L’intenzione era aiutare le persone coinvolte a orientarsi, e sostenere i ragazzi della scuola, per aiutarli a rimanere uniti ed evitare “l’importazione” tra di loro di divisioni e polarizzazioni tipiche del mondo degli adulti. Di fronte a coloro che avevano ravvisato nella vicenda i segni di una volontà di cambiare l’identità cattolica della nazione, la diocesi di Milano ha ribadito in modo sereno ma fermo che la fede cristiana non cambia affatto nel suo nucleo fondamentale. Essendo la nostra una fede incarnata, e trovandoci in una società che sta vivendo forti cambiamenti, non possiamo non interrogarci sulle conseguenze che queste trasformazioni hanno sulle espressioni della nostra fede. Essere cattolici, nel senso tecnico ed etimologico del termine, significa far vedere che siamo aperti a tutto e capaci di dialogare anche con chi non si riconosce nella fede che professiamo. Per questo non vogliamo che il confronto e il dialogo tra le religioni diventi uno scontro.
Un dialogo che, tra l’altro, è condiviso da numerose comunità espressione della fede islamica. Durante il mese del Ramadan ho partecipato più volte a un Iftar (rito della rottura del digiuno) in moschee diverse. Non ho incontrato nessuna volontà di scontro diretto odi sopraffazione del cattolicesimo, ma piuttosto la ricerca di un’alleanza per confrontarsi insieme con una società che vuole espellere Dio. Noi siamo per la libertà religiosa, non per una laicità che espelle la religione dalla vita civile e sociale. Al contrario, siamo per una vita civile e sociale capace di contenere al proprio interno la pluralità delle religioni. Le reazioni alla scelta attuata dalla scuola di Pioltello hanno confermato una sensazione di scarsa preparazione a vivere nel quotidiano, a livello locale, il confronto con un mondo come quello islamico, che ormai è tra noi ed è arrivato non per una spinta di proselitismo o di conquista religiosa, ma per motivi sostanzialmente economici. Arrivata alla ricerca di lavoro e di una vita più dignitosa, la gente s’è portata dietro la propria cultura e la propria fede. Ci ha stupito vedere il disorientamento che questo provoca, innanzitutto tra noi cattolici. Al nostro interno mi sembra d’aver notato tre atteggiamenti diversi. Il primo, tutto sommato minoritario, è la condivisione piena della posizione della diocesi, accogliendone anche la profondità della prospettiva di fede da cui nasce e la ricchezza del lavoro compiuto dalla teologia delle religioni.
Un secondo atteggiamento, ancor più minoritario, è il dissenso aperto, motivato dalla paura di uno smarrimento dell’identità cristiana che conduce a leggere il confronto nella chiave dello scontro. In realtà, questa posizione non s’accorge che la perdita dell’identità cristiana non è legata alla presenza di al-tre religioni. A qualcuno che mi diceva che quelli che vengono a vivere qui dovrebbero assumere i nostri va-lori, m’è capitato di chiedere: «Ma lei a Pasqua è stato a messa?». Mi ha stupito sentirmi rispondere, con fastidio, «Che c’entra?». Ecco, la perdita dell’identità cristiana e dei suoi valori dipende dal fatto che non li custodiamo e non li coltiviamo, non dal fatto che gli immigrati musulmani non partecipano alla messa o che ci impegniamo nel dialogo con loro. Il terzo atteggiamento, il più diffuso, è quello di un silenzio pieno di apprensione verso la prospettiva del dialogo e del confronto. Per questo abbiamo bisogno di strumenti con cui dare ragione di quanto facciamo come credenti. Non si può più semplicemente vivere una fede di comodo, accontentandosi di rimanere nel solco di quello che ci è stato tramandato, senza una rielaborazione che sia all’altezza dei tempi che stiamo vivendo e quindi della sfida del pluralismo con cui siamo chiamati a confrontarci. «Gareggiate nello stimarvi a vicenda», dice san Paolo ai Romani (12,10). Ma anche il Corano dice: «Gareggiate in opere buone: tutti ritornerete ad Allah ed egli vi informerà a proposito delle cose sulle quali siete discordi» (Sara 5,48). Il monaco cristiano e martire Christian De Chergé commenta questo inedito parallelismo affermando che da cristiani siamo invitati a «cercare un senso divino alle differenze». Non si dialoga tra le religioni per costruire la pace: questo è il livello zero del dialogo. Si dialoga perché Dio ci attende per rivelarsi a noi nel crogiuolo della differenza.